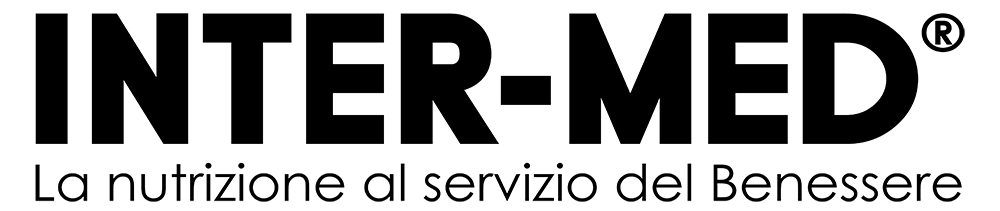Fame emotiva e PNEI: quando il corpo risponde alle emozioni
Nel mondo moderno, in cui i ritmi frenetici e lo stress cronico sono all’ordine del giorno, è sempre più comune osservare un comportamento alimentare disfunzionale noto come fame emotiva. Non si tratta di un semplice “sgarro” alimentare, ma di una complessa risposta psicofisiologica, ben spiegata attraverso il modello della PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI).
Cos’è la fame emotiva?
La fame emotiva è una modalità di assunzione di cibo non guidata da un reale bisogno energetico o nutrizionale, bensì da uno stato emotivo. È un tentativo di autoregolazione affettiva che si manifesta attraverso l’assunzione compulsiva di alimenti, spesso ricchi di zuccheri o grassi, in risposta a emozioni come ansia, tristezza, noia, rabbia, solitudine, insoddisfazione, etc.
Il modello PNEI: corpo e mente insieme
La PNEI è un modello integrato che studia le interconnessioni tra sistema nervoso, sistema endocrino, sistema immunitario e psiche. Secondo questa prospettiva, l’essere umano è un sistema complesso in cui emozioni e stati mentali influenzano profondamente la fisiologia, e viceversa.
Nel contesto della fame emotiva, la PNEI ci aiuta a comprendere:
- La risposta neuroendocrina del corpo di fronte a uno stress emotivo all’origine del rilascio di cortisolo. Questo ormone, se cronicamente elevato, stimola l’appetito, soprattutto verso cibi ad alto contenuto calorico.
- Il ruolo della dopamina: il cibo, in particolare quello “gratificante”, attiva i circuiti dopaminergici della ricompensa, generando una temporanea sensazione di piacere e riduzione della tensione emotiva.
- Le conseguenze di una “comunicazione” inadeguata tra intestino (secondo cervello, microbiota) e cervello nella modulazione dell’umore e del comportamento alimentare.
Fame fisica vs. fame emotiva: come distinguerle ?
|
Fame fisica |
Fame emotiva |
|
Insorge gradualmente |
È improvvisa e urgente |
|
Qualsiasi cibo è accettabile |
Si desiderano cibi specifici (comfort food) |
|
Si arresta con la sazietà |
Spesso continua anche dopo essere sazi |
|
Non genera sensi di colpa |
È seguita da senso di colpa o frustrazione |
Quali strategie per gestirla?
- Educazione alla consapevolezza corporea ed emotiva: imparare a riconoscere i segnali della fame reale e distinguere le emozioni che guidano il comportamento alimentare.
- Gestione dello stress.
- Coaching
- Supporto nutrizionale integrato: regolare il tono dell’umore e stabilizzare i livelli glicemici, riducendo la vulnerabilità agli impulsi alimentari.
- Supporto micro nutrizionale: promuovere la salute del microbiota intestinale attraverso probiotici, prebiotici e una dieta ricca di fibre, frutta e verdura.
Riassumendo
La fame emotiva non è un fallimento personale, ma una risposta adattiva a un disagio emotivo cronico. Attraverso l’approccio integrato della PNEI, è possibile comprendere a fondo le dinamiche che legano mente, corpo ed emozioni, offrendo all’individuo strumenti efficaci per riprendere il controllo sul proprio comportamento alimentare, promuovendo benessere e salute a 360°.